Come si classificano le particelle?
Su cosa si basa il Modello Standard delle Particelle e delle Interazioni Fondamentali? Cosa si nasconde dietro nomi quali mesoni e barioni? La risposta a domande di questo genere la si trova in oggetti matematici particolari che sono i gruppi ed è necessario acquistare familiarità con essi e con le loro proprietà per poter apprezzare fino in fondo la struttura e il contenuto delle teorie fisiche che descrivono la natura.
Il gruppo su cui è stata costruita la cromodinamica quantistica (la teoria che spiega tramite i quarks la struttura degli adroni) è SU(3), che viene rappresentato con matrici unitarie (da questo deriva la U) 3´3 (da questo deriva il 3) e aventi determinante pari a 1 (per questo vengono dette speciali e quindi la S).
Vediamo come si è arrivati alle conoscenze attuali. Nel 1961 due ricercatori, Murray Gell-Mann del California Institute of Technology e Yuval Ne’eman del London Imperial College, all’insaputa uno dell’altro, scoprirono che si possono raggruppare secondo dei diagrammi simmetrici a forma di esagono gli otto barioni con spin 1/2 (Fig. 1) e i nove mesoni con spin zero (Fig. 2); nelle figure Q sta per carica e S per stranezza, due proprietà delle particelle.
In maniera analoga si dispongono i nove mesoni a spin 1 e i dieci barioni con spin 3/2. A proposito di quest’ultimi, nel 1962 si conoscevano solo 9 barioni a spin 3/2 e Gell-Mann, basandosi sui suoi diagrammi, fece la previsione su quali dovevano essere le caratteristiche della particella mancante che fu cercata e trovata.
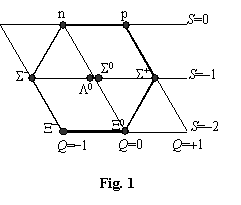
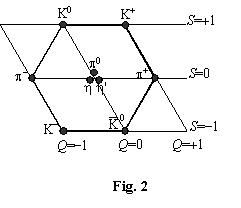
Quindi possiamo dire che questi schemi hanno rappresentato per la fisica delle particelle ciò che è stato per la chimica la tavola del sistema periodico degli elementi. Infatti, come la configurazione della tavola periodica ha portato a prevedere che gli atomi dei vari elementi non sono particelle fondamentali ma possiedono una struttura interna, così i diagrammi di cui si è appena parlato hanno rafforzato l’ipotesi che mesoni e barioni debbano possedere una comune organizzazione interna che giustifichi le loro proprietà.
Nel 1964 Murray Gell-Mann e George Zweig giunsero, indipendentemente uno dall’altro, alla conclusione che tutti i barioni allora conosciuti dovevano essere costituiti da tre quarks u, d, s (Fig. 3, da confrontare con la Fig.1, circa i due barioni centrali si nota che hanno la stessa struttura a quarks, uds, e questo perché S0 è uno stato eccitato della L0) mentre i mesoni da un quark e da un antiquark (Fig. 4, da confrontare con la Fig.2).
All’inizio si ragionava con tre soli tipi di quarks (u, d, s che sono le iniziali delle parole inglesi up, down, strange), poi, per spiegare le nuove particelle, si dovettero introdurre il quark c (charm), il quark b (bottom o beauty) e il quark t (top o true) che è l’ultimo ad essere previsto dal Modello Standard e ad essere scoperto nel 1995 al FermiLab.
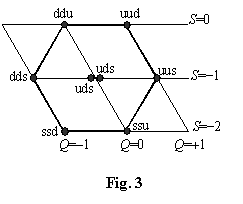
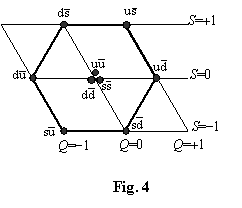
Con l’aumentare del numero dei quarks si è così passati dalla descrizione originaria SU(3) con tre quarks (u, d, s), rappresentata con diagrammi in due dimensioni, ad una descrizione SU(4) con quattro quarks (u, d, s, c), rappresentabile in tre dimensioni mediante poliedri, alla SU(5) con cinque quarks (u, d, s, c, b), ovviamente non più rappresentabile, ed infine alla SU(6) con sei quarks (u, d, s, c, b, t).
Nella Fig. 5 viene riportato un esempio di mesoni ottenibili con i quarks u, d, s, c. Confrontando le Fig. 2 e 4 con la Fig.5 si nota che il nonetto delle Fig. 2 e 4 occupa il piano centrale della Fig. 5 e che ad esso si è aggiunto lo stato cc rappresentato dalla particella hc. Quindi il piano superiore è caratterizzato da C = +1 (C sta per charm, incanto), quello centrale da C = 0, quello inferiore da C = -1.
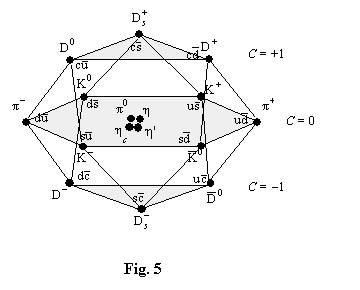
Nella seguente tabella vengono infine riassunte le proprietà dei quarks. Il concetto di spin isotopico, l’odierno isospin, in analogia con lo spin degli elettroni, fu introdotto tra il 1930 e il 1940 per spiegare le interazioni forti nucleone-nucleone all’interno dei nuclei atomici.
|
Proprietà |
|
Quark |
d |
u |
s |
c |
b |
t |
|
Q
-
carica elettrica |
|
|
|
|
|
|
||
|
Iz
-
isospin componente z |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
S
-
stranezza |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
C
-
incanto |
0 |
0 |
0 |
+1 |
0 |
0 |
||
|
B
-
bellezza |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
||
|
T
-
verità |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+1 |
||